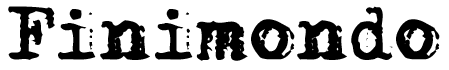Dwight Macdonald
Contro il feticismo delle masse

Al «feticismo della merce» di Marx vorrei contrapporre il nuovo moderno feticismo — quello delle masse. Più si ragiona in modo progressista, più si assume che la prova della bontà di un programma politico sia in funzione del seguito popolare che ottiene. Io oso, almeno per l’epoca presente, affermare il contrario: che, come in arte e in letteratura, la comunicabilità su vasta scala è inversamente proporzionale alla bontà di un approccio politico. Non è una cosa positiva: come nell’arte, è un fattore deformante e storpiante. Non che sia una legge eterna: in passato le idee di una sottile maggioranza, ridotta qualche volta quasi al limite di un singolo individuo, sono riuscite lentamente a conquistare sempre maggiore consenso tra i concittadini; e speriamo che lo stesso accada anche alle nostre idee. Ma tale mi sembra la nostra situazione oggi, che ci piaccia o no. Tentando di diffondere le idee politiche su scala di massa oggi si finisce per corromperle o per spogliarle di tutta la loro forza emotiva e di tutto il loro significato intellettuale. Gli stessi mezzi con cui si deve comunicare a un vasto pubblico — la radio, la stampa popolare, i film — sono infetti; il linguaggio della comunicazione di massa è infetto. Albert Camus, per esempio, redigeva il giornale di Resistenza clandestina, Combat, durante l’occupazione tedesca della Francia. Dopo la liberazione, Combat ha velocemente conquistato un vasto pubblico, e Camus è diventato uno dei più letti e influenti giornalisti politici in Francia. Però, come egli stesso mi ha detto, si è accorto che scrivere di politica in termini di grandi partiti e per le masse gli ha reso impossibile parlare della realtà, o dire la verità. E quindi si è ritirato da Combat, lasciando perdere ciò che in termini tradizionali sarebbe sembrato a un intellettuale impegnato una possibilità estremamente fortunata di diffondere le proprie idee tra le masse, guardarsi attorno e cercare un modo migliore di comunicare. Questo modo migliore, sospetto che si trovi nel parlare a poche persone di «piccoli» argomenti in modo preciso.
Quello che vale per la comunicazione, vale anche per l’organizzazione politica. I due approcci marxisti tradizionali sull’organizzazione sono quelli della Seconda e della Terza Internazionale. La Seconda pone la sua fiducia nei partiti di massa, collegati ai grandi sindacati; la Terza, in corpi di «rivoluzionari di professione» disciplinati, centralizzati, fortemente organizzati, che guideranno le masse nella rivoluzione. Superficialmente, sembrerebbe che la vasta scala della società moderna richieda dei partiti di massa per governarla, e che il potere centralizzato dello Stato moderno possa essere contrastato solo da un partito rivoluzionario egualmente centralizzato e fortemente organizzato. In realtà sembra che sia vero proprio il contrario: lo Stato può fare a pezzi tali gruppi, che siano organizzati come partiti di massa o come i corpi di élite bolscevichi, nel momento in cui mostrano i segni di diventare una seria minaccia, proprio perché essi lottano contro lo Stato sul suo stesso terreno, perché competono con lo Stato. Il potere totale che ha assunto lo Stato oggi fa sì che solo qualcosa su un piano diverso possa opporvisi, qualcosa che combatta lo Stato da una posizione di vantaggio che le armi dello Stato possono colpire solo con difficoltà. [...].
Tutto questo significa che azioni individuali, fondate su convinzioni morali, possiedono maggiore forza oggi di quanta ne avessero due generazioni fa. Come mi ha scritto recentemente un corrispondente inglese: «La ragione decisiva per l’Obiezione di Coscienza è senza dubbio il fatto che dà peso al sentimento personale. Nel mondo di oggi, il più piccolo segno di rivolta individuale assume un peso sproporzionato rispetto al suo reale valore». Infatti, nell’arruolare gli uomini in quella società totalitaria che è l’esercito degli Stati Uniti, gli esaminatori respingono spesso chi ha dichiarato apertamente di non voler entrare nell’esercito perché convinto di non potervi essere felice. Possiamo essere certi che ciò non sia dovuto a simpatia, ma piuttosto al fatto che, in quanto uomini pratici, gli esaminatori sanno che tali soggetti sarebbero «problematici» e che il buon funzionamento di un vasto meccanismo potrebbe essere inceppato da un simile granello di sabbia proprio per la complessità dei delicati ingranaggi della macchina.
Un’altra conclusione è che il gruppo di azione contro Il Nemico è molto efficace quando è molto spontaneo e lasco nell’organizzazione. L’opposizione dei club romantici della gioventù tedesca (Edelweiss, Black Pirates) ha probabilmente danneggiato il nazismo più che i vecchi partiti e sindacati. Infatti, la stampa mondiale riporta che recentemente si è scoperta una lista segreta di dirigenti britannici da eliminare dopo l’invasione dell’Inghilterra, in questa lista la massima priorità non è data a sindacalisti o a capi dei partiti di sinistra ma a noti pacifisti.
Per questo, appare necessario incoraggiare comportamenti non rispettosi, scettici, che mettono in ridicolo lo Stato e tutte le autorità, invece che mettere in piedi un’autorità alternativa. È la differenza tra un attacco frontale su tutta la linea e rapide stoccate laterali nei punti in cui Il Nemico è più debole, tra il conflitto organizzato su vasta scala e le operazioni di guerriglia. I marxisti preferiscono il primo: i bolscevichi insistono sulla disciplina e sull’unità per contrastare quelle del Nemico; i riformisti tentano di vincere il potere del nemico mettendo grandi masse di votanti e di membri del sindacato sul piatto della bilancia. Ma lo status quo è troppo forte per essere rovesciato da simili tattiche; e, peggio, esse mostrano la tendenza antipatica a far passare dalla parte del Nemico
Egoismo, o la radice è l’uomo
È ovvio che l’azione individuale non può mai rovesciare lo status quo, ed è anche ovvio che perfino una spontanea ribellione di massa sarebbe inutile a meno che agisca in base a qualche tipo di programma e a meno che non si prendano determinate elementari misure di coordinamento e di organizzazione. Ma oggi ci troviamo di fronte a questa situazione: le masse non agiscono nel senso che la maggior parte dei lettori di questa rivista definirebbe come un fondamentale miglioramento della società. Il solo modo in cui, al momento, si può agire in questo senso (senza limitarsi a «fare il verbale» per la musa della storia marxiana con risoluzioni e manifesti «contro la guerra imperialista», «per la rivoluzione proletaria internazionale», ecc.) sembra essere quello delle azioni simboliche, basate sull’insistenza di una persona sui propri valori, e quello della creazione di piccoli gruppi fraterni che appoggino tali azioni, tengano vivo il senso dei nostri obiettivi ultimi, e funzionino sia come lievito nella società di massa sia come polo di attrazione per i suoi membri più alienati e frustrati. Queste posizioni individuali (prese da molti Obiettori di Coscienza, anche da un manipolo di scienziati atomici in questo paese e in Gran Bretagna che si sono semplicemente rifiutati di lavorare alla Bomba) hanno due vantaggi rispetto alle attività di quanti sostengono che l’azione di massa sia oggi possibile:
1) Lanciano un immediato appello ai cittadini, l’appello dell’individuo che è abbastanza coraggioso e serio per opporsi, anche da solo se necessario, all’enorme potere dello Stato; questo incoraggia altri a resistere un po’ di più di quanto altrimenti farebbero nella loro vita di tutti i giorni, e inoltre conserva quei vivai della protesta e della ribellione da cui potrebbero in seguito sorgere cose più grandi.
2) Conservano almeno la vitalità rivoluzionaria e i principi dei pochi individui che assumono quelle posizioni, mentre quanti intraprendono azioni di massa diventano, se restano fedeli ai loro principi, indeboliti e corrotti personalmente dal dover costantemente sottomettersi al modello di comportamento del Nemico — e molto più corrotti del borghese che si sente tutt’uno con quel modello (chiunque abbia frequentato il movimento trotzkista, per esempio, come ho fatto io, sa che a proposito di comportamento personale accettabile, sincerità, e rispetto per le opinioni dissenzienti, i «compagni» sono di solito molto peggiori di un normale agente di cambio). D’altra parte, se scendono a compromessi con i principi per stabilire un contatto con le masse, diventano semplicemente parte delle forze del Nemico, come accade nel caso del British Labour Party e dei socialisti francesi. I marxisti scherniscono l’idea dell’azione individuale e della responsabilità individuale sostenendo che a noi importa solo «salvare le nostre anime». Ma cosa c’è di terribile in questo? Non è meglio salvare l’anima di qualcuno invece di perderla? (E senza neppure conquistare il mondo!).
Il primo passo verso un nuovo concetto di azione politica (e di moralità politica) è per ognuno decidere cosa secondo lui è giusto, cosa lo soddisfa, cosa egli desidera. E poi esaminare con metodo scientifico l’ambiente per stabilire come ottenerlo — o, se non lo può ottenere, per capire cosa può avere senza compromettere i suoi valori personali. L’egoismo deve essere restituito alla rispettabilità nei nostri schemi di valori politici. Non che l’individuo esista separatamente dai suoi vicini, nel senso di Max Stirner. Sono d’accordo con Marx e Proudhon che l’individuo può definire se stesso solo nelle sue relazioni sociali. Ma il problema è che queste siano davvero relazioni umane e non concetti astratti di classe o di storia. È stato spesso osservato che le nazioni — e, potrei aggiungere, le classi, perfino il proletariato — hanno un livello di comportamento etico più basso di quello che hanno gli individui. Se anche tutti i vincoli giuridici fossero rimossi, possiamo essere sicuri che poche persone si dedicherebbero in modo esclusivo all’omicidio o che mentirebbero costantemente ai loro amici e familiari; al contrario i dirigenti più rispettati delle attuali società, i militari e i capi politici, nelle loro funzioni pubbliche, finiscono per diventare specialisti nel mentire e nell’uccidere. Sempre, naturalmente, per nobili obiettivi, «per il bene dell’umanità».
Un amico lo ha detto bene in una lettera che ho ricevuto alcuni mesi addietro: «Finché la moralità è tutta nei luoghi pubblici — politica, Utopia, rivoluzione (anche quella nonviolenta), progresso — i nostri costumi privati continuano a essere una nauseabonda mistura di condotta cavalleresca e cinismo: si può essere contrari o favorevoli, a seconda dei punti di vista. Siamo tutti contrari all’offesa politica, amiamo tutti l’umanità, ma gli individui sono in qualche modo duri da amare, e ancora più duri da odiare. Sogni dorati, sogni umanitari, non c’è la differenza purché profumino. Nel frattempo, proteggi qualsiasi puttana, combatti qualsiasi guerra, ma non sposarti e non metterti contro il capo — è troppo pericoloso [...] No. La nostra unica possibilità è provare a perseguire un egoismo privato più piccolo e onesto che possiamo. Non sei d’accordo che non si può provare una partecipazione morale nei confronti dell’Umanità? È troppo grande».
O per esprimerlo in termini più generali. Il progresso tecnologico, l’organizzazione dall’alto della vita umana (quello che Max Weber chiama «razionalizzazione»), la fede esagerata nel metodo scientifico dei due secoli passati — tutto ciò ci ha portato, letteralmente, in un vicolo cieco. La tendenza è ora chiara: guerra atomica, collettivismo burocratico il «consolidarsi del nostro proprio prodotto in un potere oggettivo che ci sovrasta, che cresce fino a sfuggire al nostro controllo, che contraddice le nostre aspettative, che annienta i nostri calcoli [...]». Mi sembra assurdo tentare di lottare contro questa tendenza, come fanno i progressisti di tutti i tipi, con le stesse forze che l’hanno posta in essere. Dobbiamo dare forza alle emozioni, all’immaginazione, ai sentimenti morali, al primato dell’essere umano individuale, dobbiamo ristabilire l’equilibrio che è stato rotto dall’ipertrofia della scienza negli ultimi due secoli. La radice è l’uomo, qui e non altrove, adesso e non più tardi.
[Politics, luglio 1946]