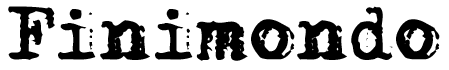Il nostro male viene da più lontano
Finale scontato

Alain Badiou
Einaudi, 2016
Ci sono libri che, prima di iniziare a leggerli, sai già dove andranno a parare, e quale sia lo scopo del loro autore. Questo libretto del filosofo francese è uno di quei casi. Non si tratta in realtà di un libro vero e proprio, bensì della trascrizione di un seminario tenuto in un teatro francese il 23 novembre 2015; a dieci, giorni, quindi, dai massacri parigini per mano degli islamisti. Ed è proprio questo lo spunto del seminario: analizzare l’ondata di violenza che ha appena scosso le coscienze francesi e mondiali, e cercare di comprenderne le radici profonde.
Non deve essere stato facile affrontare la questione a caldo, provando a dare una visione differente da quella scatenata dalla canea mediatica di quei giorni, ricordando che massacri del genere l’Occidente li compie, ogni giorno, in vari angoli del mondo. Badiou spiega quindi che gli attentati di Parigi, che hanno colpito degli occidentali, tendono a sollecitare un riconoscimento identitario che, a sua volta, porta a stringersi attorno allo Stato e questa «idea trasforma la giustizia in vendetta» tanto che «la polizia […] uccide gli assassini appena li trova». Il limite di questa affermazione, però, è nella idea dell’autore che associa la giustizia al “giusto” e la vendetta al “male”, ma non considera che l’idea di vendetta non per forza deve essere connaturata allo Stato e alle garanzie offerte dal suo diritto, cosa che permetterebbe di vedere del “giusto” proprio nella tanto vituperata vendetta. Del resto, come ben si capisce dal resto del suo discorso, il filosofo è un fedele amante dello Stato, di cui cambierebbe solo la forma...
Se l’analisi di base di Badiou è condivisibile quando indaga la struttura del mondo contemporaneo alla luce della vittoria del capitalismo mondiale, nella sua attuale forma che chiama «capitalismo globalizzato», smette di esserlo quando afferma che la radice dei mali che affliggono il pianeta sia frutto della scomparsa di un’altra idea, che per lui coincide esclusivamente con l’idea del comunismo. Il pensiero che possa esistere un’altra idea di mondo, al di fuori e contro il controllo statale, non pare sfiorarlo minimamente; da buon marxista ortodosso, nutre infatti un odio viscerale nei confronti dell’anarchia; secondo lui, è proprio questa forma di non governo ad avere implementato i problemi e le crudeltà del mondo, in quanto in molte zone, dopo il dissolvimento degli Stati-nazione, all’interno di quella nuova forma che assumono i territori, che Badiou definisce col termine di «zonizzazione», «vigerà una sorta di semi-anarchia, di bande armate controllate o incontrollabili» che «non impedirà lo sviluppo degli affari, e anche meglio di prima», perché «in una zona in cui ogni vera potenza statale è scomparsa, l’intero microcosmo delle imprese opererà senza grandi controlli». Insomma, il problema è che l’ascesa al potere del capitale multinazionale e la progressiva estinzione dello Stato-nazione, hanno ridotto al lumicino controlli, garanzie e diritti.
Non a caso Badiou insiste più volte sul dato che, al mondo, due miliardi di essere umani siano esclusi da tutto, non essendoci lavoro per tutti, e non potendo così costoro essere produttori – quindi guadagnare – e di conseguenza consumatori – quindi poter acquistare quanto occorre per la sopravvivenza quotidiana. Non un parola di critica al lavoro in quanto sistema di sfruttamento, o al denaro, dalla cui disponibilità può dipendere la vita o la morte di molti.
Quanto alle motivazioni che spingono dei giovani occidentali a compiere massacri simili a quelli di Parigi, Badiou si addentra in un discorso psicoanalitico, attraverso il quale identifica delle «soggettività tipiche» e, all’interno di esse, una in particolare che definisce «soggettività del desiderio di Occidente». Sarebbe proprio questo desiderio, secondo lui, a portare alcuni giovani, immigrati di seconda o terza generazione, a trasformarsi in assassini, a causa della mancata realizzazione del desiderio stesso. Ma è proprio vero che sia questa frustrazione la causa? Che sia il mancato raggiungimento del benessere e dell’adeguamento ai valori occidentali a spingere dei giovani ad uccidere e farsi uccidere? E se invece fosse l’acquisizione di una consapevolezza, che gli permette di riconoscersi come colonizzati nelle terre d’origine, estranei, esclusi e rifiutati nella terra d’approdo, e quindi sempre messi al margine della società, a prescindere dal territorio in cui vivono, vivendo quindi nella carne la marginalizzazione a cui li sottopone quel capitalismo globalizzato? A quel punto, la mancata prospettiva di una vita degna ovunque, e l’assenza di etica, può spingere a riempire di esplosivo la propria rabbia, incanalandola nel modo peggiore; ma quella religiosa non può essere considerata solo una copertura di facciata, una forma ideologica di nascondimento, se si considera l’intrinseca violenza insita in ogni religione.
Interessante è la parte in cui si analizzano e si confrontano quelle che vengono definite civiltà e barbarie, dove – da questa parte del mondo – la prima è rappresentata dalla cultura occidentale, la seconda dall’oscurantismo islamista. Per il filosofo è fin troppo facile spiegare che, alla luce di tutti gli stermini causati quotidianamente dall’Occidente, questo non può certo vantarsi di essere civile, ma altrettanto barbaro di quei popoli barbari che vorrebbe combattere. L’errore di fondo, però, sta nel concetto stesso di barbarie: il messaggio che passa è che, ammazzando in maniera indiscriminata, che a farlo sia l’Isis o gli Stati occidentali, esso sia comunque un atto barbarico. Sarebbe forse più corretto affermare che, col progredire della civiltà, l’estremo sviluppo del suo pensiero fattosi mondo e della sua tecnica, i massacri e gli stermini di ogni tipo hanno toccato picchi di crudeltà forse mai raggiunti. Ma riflettere su ciò significa anche capire che tra civiltà e barbarie non necessariamente la prima è migliore della seconda, e questo crea sgomento, perché spinge a porci la domanda su dove stiamo andando e su che mondo abbiamo creato...
Infine, si arriva alla conclusione che si sapeva di trovare. Dalle parole del filosofo francese si nota un certo rammarico per il fatto che i poveri, gli esclusi da tutto, non incanalino la loro rabbia all’interno di una ideologia che si opponga al capitalismo, ovvero tendano al comunismo. Orfano di un mondo oramai scomparso, nutre la recondita speranza che questa umanità offesa possa trasformarsi nel nuovo soggetto rivoluzionario. Gente come lui non può farne a meno. Incapaci di immaginare un avvenire differente da tutto ciò che è Passato, tentano di riciclare un futuro ormai alle spalle.
Chissà che non avesse ragione Cioran quando affermava che “l’originalità dei filosofi si riduce ad inventare termini”.
[6/10/2016]