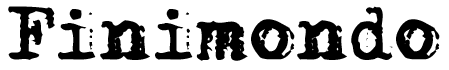La Comune ungherese

(marzo 1919 – marzo 1937)
Aldo Aguzzi
Circa i fatti svolti nell’Ungheria nel 1918-19 v’è sempre stata una strana indifferenza. Essi non impressero nella memoria del proletariato tracce molto profonde. A causa, forse, d’una quasi assoluta mancanza di documentazione non si è valutata la rivoluzione ungherese in tutta la sua eccezionale grandiosità. Il suo vero carattere, e le cause reali tanto deI suo avverarsi quanto della sua catastrofe furono sempre misconosciute, oppure ignorate. Si suppone generalmente ch’essa costituì una audace e sfortunata gesta del «bolscevismo», ed il più diffuso giudizio critico applicato alla sua tragica scomparsa si circoscrive, per gli uni, alla supposta inettitudine del popolo magiaro, e per gli altri alla scarsa energia con la quale i principi del «marxismo-leninismo» ed i metodi coercitivi della «dittatura del proletariato» sarebbero stati adottati ed applicati da Béla Kun e dai suoi luogotenenti.
Questo saggio però polverizza tali errori e leggende (*). A Pierre Ganivet, nella sua qualità d’appassionato studioso dei problemi danubiani, spettava rendere giustizia alla Comune ungherese. Col solo concorso d’una serrata documentazione, d’una meticolosa cronologia e di un’analisi acutissima, egli riesce a comporre un quadro completissimo ove situazioni, fatti e uomini vengono collocati nella viva luce della verità.
La Comune ungherese non fu il risultato d’una spasmodica convulsione, ma d’una rivoluzione vera o grandiosa, benché inconclusa. Nei limiti d’una esistenza effimera, fra tutti i tentativi d’emancipazione operaia e di superamento umano, essa risalta come uno dei più luminosi e promettenti. La sua ripercussione sui destini dell’Europa post-bellica fu immensa. Fu una rivoluzione assassinata, non abortita. La sua perdizione non si dovette che ad un crimine orrendo; duplice crimine la cui responsabilità ricade esclusivamente sulla democrazia borghese, e su quei settori politici che, considerando la massa operaia congenitamente incapace di difendere i propri interessi ed elaborare il proprio avvenire, s’arrogano la funzione storica d’infallibili conduttori del proletariato.
Anziché peccare d’immaturità rivoluzionaria, in quei giorni di fuoco e d’angustia in cui «vinti» e «vincitori» uscivano, ugualmente dissanguati, dalla geenna della grande guerra, l’Ungheria sommava in sé, più d’ogni altro paese, le condizioni obiettive che ad una crisi rivoluzionaria conferiscono forza di fatalità, e le condizioni soggettive atte a risolvere tale crisi, in una magnifica sintesi costruttiva. Attraverso lo sgretolarsi dell’Impero degli Asburgo, le nazionalità secolarmente oppresse che l’integravano si risvegliavano a vita indipendente. Contemporaneamente, nell’Ungheria, l’antico disagio d’una popolazione di 14 milioni di contadini — dei quali 11 milioni e mezzo veri servi della gleba — giungeva al parossismo. Si risollevavano perciò, ineludibili, i due problemi fondamentali — latenti e concomitanti già dai lontani tempi di Kossuth: quello dell’autonomia nazionale e quello della riforma agraria per la distruzione d’ogni vestigia feudale. Combinati, tuffati nell’atmosfera rovente respirata in quegli anni da tutta l’Europa, questi due elementi, cioè il politico e l’economico, costituivano un formidabile potenziale rivoluzionario, che solo l’errore od il terrore potevano frustrare.
Il regime transitorio del conte Karolyi non fu che un vano tentativo di separare il problema economico da quello politico e di tarpare le ali alla rivoluzione ungherese. Paladino dell’indipendenza nazionale, democratico, simpatizzante degli Alleati, legato ai principi giacobini del 1793, Karolyi tendeva ad impedire che la marcia della rivoluzione valicasse i confini d’una lotta anti-feudale però conservatrice della proprietà privata. Nel raggiungimento di questi propositi, egli contava sull’appoggio dei governi alleati che avevan sostenuta e guadagnata la guerra del 1914-18 in nome dei sacri principi di nazionalità, autodeterminazione e democrazia. Oltreché in una affinità ideale, calcolava sicuramente che la borghesia democratica occidentale era poderosamente interessata a consolidare i frutti della sua vittoria, garantendo un’Ungheria indipendente, la definitiva scomparsa dell’Impero asburgico e della potenza teutonica. Però sotto la maschera wilsoniana si celava il volto felino di Clemenceau. La «democrazia» rappresentata dalle potenze vincitrici abbandonò e tradì la repubblica democratica di Karolyi, come più tardi avrebbe tradito tutte le altre democrazie pericolanti. Inutilmente allora alcune voci segnalarono che il sabotaggio alla Repubblica ungherese, tiepidamente democratica, costituiva per l’Intesa un enorme pericolo. «Karolyi — protestava su L’Action Française del 24 marzo 1919 il nazionalista Jacques Bainville, unendo la sua voce a quella di liberali e socialisti — si è offerto a noi nella nostra lotta contro la Germania. Eppure lo si è lasciato cadere». Così pure R. Recolmy su Le Figaro (28 marzo) ed E. A. Bartlett sul Daily Telegraph (24 giugno 1919) segnalavano che Clemenceau, al suo timore d’una rivoluzione, sacrificava i frutti della «vittoria» preparando il ritorno dell’assolutismo imperialista nell’Europa Centrale. Ma questi protestatari non comprendevano — e non lo comprendeva Karolyi — che la «democrazia» apparentemente consolidata dalla vittoria bellica entrava nella sua fase declinante col repentino inasprirsi delle sue contraddizioni di fronte alle esigenze egualitarie e redentrici del proletariato. E l’aiuto negato alla Repubblica ungherese nata il 4 ottobre 1918 fu invece prestato ad Horthy!
Il proletariato organizzato costituiva nell’Ungheria l’unica forza capace d’impedire una catastrofe. Sotto la pressione dell’agitazione operaia e contadina e del pericolo esteriore, Karolyi consegnò il potere a Béla Kun. Il merito di Karolyi consiste nell’aver preferito passare alla storia come una scialba figura piuttosto che come un sanguinario.
Effettivamente egli non era all’altezza del suo compito. Come afferma P. Ganivet, aveva inutilmente tentato di controllare degli avvenimenti più forti di lui. Però gli avvenimenti dovevan essere anche più forti di Béla Kun.
Béla Kun fu chiamato in scena nell’apogeo del fermento rivoluzionario delle masse operaie e contadine. Una delle più sorprendenti rivelazioni del libro che presentiamo è la dimostrazione delle profonde tradizioni rivoluzionarie, dell’intensa attività e della capacità d’autogoverno del popolo magiaro. Ben lungi dall’essere la temeraria, prematura avventura d’una élite di dirigenti, il movimento ascensionale della rivoluzione ungherese culminato nella proclamazione della Comune (21 marzo 1919) fu di gestazione prettamente popolare, con profondissime radici nel passato e presente storico-sociale del paese. I capi politici candidati al potere non avevano fomentato né iniziato la rivoluzione. S’inserirono nella rivoluzione quasi all’ultimo momento, non permanendovi che come ingrediente inassimilabile e negativo. Il ruolo disimpegnato della massa produttrice e quello dei suoi «dirigenti» in uso del potere, furono sempre diversi e frequentemente contrapposti.
Béla Kun ed i suoi seguaci importavano la neonata ideologia leninista della dittatura proletaria, ossia del monopolio della cosa pubblica durante il processo rivoluzionario, in un ambiente fertile alle creazioni della libera iniziativa popolare. Nell’Ungheria i primi germi rivoluzionari non eran stati sparsi da politicanti e da idolatri dello Stato, bensì da apostoli ed agitatori i quali, ispirati alle idee d’un Tolstoi o d’un Kropotkin, propiziavano l’azione diretta, autonoma, dal basso, delle forze proletarie. Perciò le organizzazioni di classe del proletariato magiaro si erano realizzate fuori dal clima politico. Non assunsero forma di «partito», bensì di cooperativa, di gruppo ideologico e culturale o di sindacato. I conati insurrezionali manifestatisi nell’Ungheria nell’ante-guerra e poi con crescente intensità in piena conflagrazione non furono dei volgari putsch per la conquista del potere. Furono rivolte di massa, però d’una massa perfettamente cosciente della sua missione, come dimostra la spontanea germinazione di soviet liberi, di consigli di operai, contadini e soldati. Lo stesso Partito Comunista ungherese, dove le forze libertarie eran così ingenti e dinamiche, non fu un partito «bolscevico» e la formula «dittatura proletaria» da esso adottata non ebbe un senso strettamente leninista.
Come ogni rivoluzione dove le masse proletarie disimpegnano una funzione attiva e non sono irretite dall’autoritarismo, la rivoluzione ungherese fu straordinariamente feconda in realizzazioni. La Comune d’Ungheria ebbe appena una fugace durata di 136 giorni. Però questo breve periodo bastò alla perfetta organizzazione, su basi socialiste, della produzione rurale ed industriale, alla riorganizzazione dei trasporti, ed alla preparazione di un’opera culturale la quale, se non fosse stata affogata nel sangue, avrebbe stupito il mondo.
Béla Kun e gli altri elementi nutriti di principi bolscevichi tentarono invano — però lo tentarono! — di soffocare lo sforzo creatore della massa produttrice imponendole il giogo del totalitarismo statale. Tutte le cause interne che contribuirono alla scomparsa della Comune ungherese vanno ricercate, senza eccezione, nei contrasti suscitati dall’intromissione governativa nello svolgimento della rivoluzione. Andrés Révész, nel suo libro Béla Kun y el Comunismo Húngaro (1919), segnala una manovra del «dittatore» per sopprimere l’autonomia sindacale. In una conferenza pronunziata il 14 maggio 1919 Béla Kun domandava: «Quali saranno nell’avvenire le relazioni fra i sindacati ed il partito?». Ed affermava: «I sindacati devono conservare la loro coesione ed il loro carattere economico. Il partito è un’organizzazione politica. Il partito deve essere l’avanguardia del socialismo». Questa intenzionale discriminazione fra economia e politica nascondeva il proposito d’inibire ai sindacati ogni ingerenza nelle risoluzioni orientatrici della rivoluzione e di sottometterli alla dittatura del partito. Però tali propositi trovarono l’opposizione più ferma ed ostinata. J. Weltner, in nome del sindacato dei tipografi, affermò sul Nezpava che «i sindacati non si lascerebbero ridurre al ruolo d’organi puramente consultivi». S. Iunfi, commissario d’istruzione pubblica, scriveva sulla rivista Az Ember (L’Uomo): «Si è comprovato che né l’organizzazione del partito, né i consigli di fabbrica (soviet), né altri organismi della classe proletaria furono capaci d’organizzare l’esercito attuale e che solo i sindacati possiedono la potenza e la capacità per questo grande lavoro». La politica di Béla Kun cominciava a scavare abissi fra il potere da lui rappresentato ed i sindacati: quei sindacati al cui sforzo le sorti della rivoluzione erano affidate!... Alla fine di maggio (1919) Payer, rappresentante del sindacato metallurgico con oltre 30.000 aderenti, passò all’opposizione. Da queste dissidenze provocate dall’alto la Comune non usciva certamente rinsaldata.
I sindacati furono i creatori della nuova economia. Non furono responsabili però della crisi da cui essa fu tormentata. Alcune cause di crisi eran estranee al regime. Altre, d’indole interna, furono di diretta responsabilità dello Stato. Così come Karolyi aveva provocato il caos nell’economia agraria, e reso inutile la riforma promulgata dal suo governo, inviando ad applicarla sciami di funzionari, il governo di Béla Kun perturbò la marcia della ricostruzione industriale, amministrata dai sindacati e dalle cooperative, tentando d’assoggettarla ad una nuova burocrazia corrotta ed inetta. Eugenio Varga, il noto economista allora commissario di «produzione sociale», confessava il 15 giugno 1919 al Congresso Generale dei Soviet: «Dovemmo creare una burocrazia per sostituire i 20 o 30.000 capitalisti che avevano organizzato la produzione. Devo riconoscere che la nuova burocrazia non è affatto l’organo ideale che auspichiamo». Incompetenza, voracità, lusso, abusi d’ogni sorta caratterizzavano i nuovi rappresentanti dello Stato. Essi furono in gran parte responsabili della depressione della produzione e della scissione fra i campi e la città.
Malgrado ciò, e forse perché appena all’inizio, questi mali non gravarono decisamente sulle sorti della Comune. La situazione interna era eccellente. Lo dimostrò il rapido soffocamento del colpo controrivoluzionario dei cadetti. Quale fu dunque la vera sventura della Comune? Fu quella di conferire pieni poteri a Béla Kun nell’amministrazione della guerra e della politica estera.
Béla Kun, onde potenziare lo Stato, volle trasformare le milizie rivoluzionarie in esercito. Così ebbe a distruggere l’entusiasmo comunalista, l’idealismo e lo spirito di sacrificio della forza armata, la quale si contaminò d’elementi neutri od apertamente controrivoluzionari. D’altra parte, la sorte della Comune ungherese era affidata a quella della rivoluzione europea. Non dimentichiamo che nel 1919 la rivoluzione proletaria era, in Europa, all’ordine del giorno. La Russia si trovava in piena lotta rivoluzionaria. Fiamme di rivoluzione in Austria, Baviera, Italia, nella zona danubiana. Per la Comune magiara non v’era che una politica estera possibile. Era quella di Danton: «audacia!». Non v’era possibilità di salvezza per ognuno dei movimenti rivoluzionari agitanti molti paesi in quel periodo, fuorché nello sforzo reciproco d’appoggiarsi, propagarsi ed unificarsi. Béla Kun, al contrario, non pensava all’aiuto del proletariato; pensava piuttosto all’aiuto od almeno all’indulgenza degli statisti «democratici» coi quali procurava e sperava intendersi. Negoziava con Clemenceau, mentre Clemenceau covava Horthy. La Cecoslovacchia proclamava, con Janusek alla testa, la propria Comune. Però Béla Kun pugnalava la rivoluzione cecoslovacca con l’ordine di paralizzare le operazioni militari del 17 giugno (ordine fatto consigliare dal «Tigre») nello stesso modo che il bolscevismo russo aveva pugnalato la rivoluzione tedesca col trattato di Brest-Litwosk. Abbandonata dunque la Comune ungherese alle sue proprie forze, staccata dal proletariato europeo, doveva soccombere sotto i colpi degli eserciti armati dalla «democrazia alleata». E questa rivoluzione, così piena di vita e di promesse quanto alle sue risorse interne, fu affogata in un’orgia di sangue e persecuzioni non terminata neppur oggi dopo quasi quattro lustri!
Le conclusioni sono amare, ma istruttive. Dando morte alla Comune ungherese, la Democrazia dava morte a se stessa. Da allora in avanti la democrazia non poteva che continuare ad essere pre-fascismo o filo-fascismo. Però la rivoluzione ungherese, se non poteva essere salvata dalla democrazia di governo, avrebbe potuto e dovuto essere salvata dal proletariato mondiale. Anche qui le parole che Pierre Ganivet dedica a Karolyi si applicano ai «leader» della dittatura proletaria e della Socialdemocrazia che guidavano in quegli anni il proletariato europeo: «…non volle comprendere che solo il popolo è capace di decidere da se stesso la propria sorte e che in una rivoluzione solo le misure estreme danno risultato». L’assenza di «misure estreme» ci presenta oggi un’Europa in cui molti popoli soffrono la stessa tragedia del popolo ungherese. Lo spirito di Clemenceau e di Horthy è trionfato in Italia, in Germania, in Austria. Le cause di queste disfatte furono sempre identiche. Identiche le responsabilità.
Durante vent’anni la «democrazia» ha continuato ad ingannare i popoli, ed i rivoluzionari di Stato hanno continuato a condurli al disastro. Solo oggi un popolo che ha fatto tesoro di tragiche esperienze tenta riscattarsi dalla lunga catena di disfatte con una «misura estrema».
Contempliamo oggi la Spagna in armi, sperando e trepidando. Anche lì esiste un proletariato eroico, allenato alla scuola delle idee libertarie: un proletariato che da solo ha creato contro le orde della forca un esercito liberatore ed elevato contro un mondo putrefatto un nuovo mondo. Strane analogie vincolano il proletariato magiaro al proletariato iberico...
Però non esistono, ancor oggi, i Clemenceau, i Béla Kun, i Francy d’Esperey, e tutta la farsa oscena della «democrazia» e dell’autoritarismo in agguato?
È la storia che si ripete?
No. La storia non si ripete mai. Semplicemente, essa risuscita situazioni analoghe, torna a sollevare gli stessi problemi, ai quali si dà una soluzione vecchia o nuova, sbagliata o giusta, secondo che le successive generazioni abbian saputo o no trarre profitto dall’esperienza. Il proletariato spagnolo deve oggi risollevare il masso lasciato cadere da altri popoli che furono schiacciati sotto il suo peso. Però lo sforzo del proletariato spagnolo non sarà l’inutile lavoro di Sisifo. Il suo occhio è all’erta, tesi i suoi muscoli. Che il mondo della libertà e della civiltà sappia abbracciarne e difenderne la causa.
Marzo 1937
(*) Il presente scritto è la riproduzione dell’originale italiano del «prologo» alla prima versione spagnola del libro di Pierre Ganivet intitolato La Comuna Húngara, pubblicato a Buenos Aires nel 1937. L’edizione originale apparve in Francia nel 1926 sotto il titolo La Commune hongroise et les anarchistes. Pierre Ganivet era lo pseudonimo di Achille Dauphin-Meunier, che successivamente avrebbe abbandonato le idee anarchiche e si sarebbe convertito al cattolicesimo.